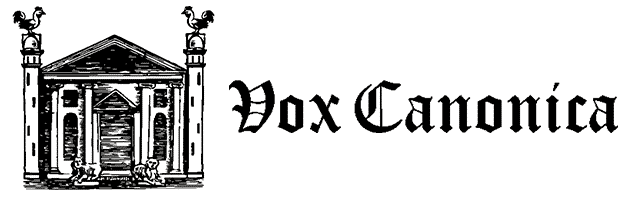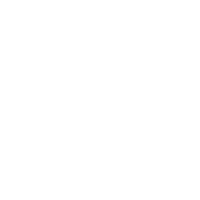Renato Di Bosso, in volo sul Garda, 1937-38, Olio su tavola, collezione privata
Introduzione
Nel sistema canonico, il concetto di sospensione assume una varietà di forme e di significati, spesso tra loro differenti per natura, presupposti e finalità. Con il presente contributo vogliamo trattare gli essenziali dati caratterizzanti di una specifica forma di sospensione degli atti del ministero sacerdotale – non codificata, ma sempre più rilevante nell’esercizio della potestà di governo – ossia quella disposta per via amministrativa. Nella prassi, poi, come vedremo, si rappresenta la necessità di distinguere tra essa forma di sospensione e le altre previste dall’ordinamento canonico, in particolare quella di natura penale.
Le varie specie di sospensione
Alla luce delle premesse esposte, appare opportuno soffermarsi sui diversi significati che il termine “sospensione” può assumere in ambito canonico. Al riguardo, occorre distinguere tra:
- sospensione penale giudiziale (can. 1333-1334): si tratta di una censura, comminata nel contesto di un processo penale giudiziale, appunto;
- sospensione penale amministrativa: inflitta non attraverso un processo giudiziale, ma nell’ambito di un procedimento penale amministrativo. Anche in questo caso, dunque, la sospensione ha natura penale;
- sospensione cautelare (can. 1722): può essere disposta anche durante la fase di investigatio praevia per i delicta graviora, oppure nel corso del processo per altri delitti;
- sospensione per irregolarità o impedimento (can. 1044): presuppone l’accertamento delle circostanze peculiari indicate dalla normativa, gravi al punto da precludere l’esercizio del sacro ministero;
- sospensione disciplinare: conseguente a una condotta posta in violazione di doveri legati all’ufficio, ma non necessariamente inquadrabile come delitto;
- sospensione speciale: riguarda casi particolari, come quello del chierico dimesso da un Istituto di vita consacrata (can. 701) o coinvolto in un procedimento di nullità dell’Ordine sacro (can. 1709 § 2);
- sospensione amministrativa: è un provvedimento non previsto da un canone specifico, che viene adottato motu proprio da un’autorità ecclesiastica mediante atto amministrativo.
Proprio su quest’ultima fattispecie – la sospensione amministrativa – vogliamo soffermarci, poiché la sua adozione solleva questioni delicate di legittimità, di interpretazione giuridica e di garanzia dei diritti fondamentali dei chierici.
Natura e limiti della sospensione amministrativa delle facoltà ministeriali
Con riferimento alla sospensione delle facoltà ministeriali per via amministrativa è opportuno segnalare la necessità di evitare sovrapposizioni illegittime tra la stessa e le altre specie di sospensione suesposte. In particolare, non è remoto il rischio nella prassi di procedere in via amministrativa con un provvedimento che, nella sostanza e negli effetti, assume la portata di misura cautelare, mancando tuttavia i presupposti legali per la sua legittima comminazione. Allo stesso modo, è opportuno scongiurare la possibilità che talune sospensioni amministrative celino delle vere e proprie pene canoniche che, per la loro inflizione o dichiarazione, richiedono un accertamento definitivo del delitto contestato, nelle forme dei procedimenti penali amministrativo o giudiziale, con l’osservanza del principio del contraddittorio e nel rispetto del diritto di difesa dell’accusato.
L’esigenza di vagliare attentamente i presupposti e le condizioni per la comminazione del provvedimento in esame assume rilievo peculiare se si considera che la sospensione amministrativa, come detto, non trova collocazione espressa in un canone del Codice, motivo per cui essa è qualificata come fattispecie innominata.
L’Autorità ecclesiastica potrebbe giustificare tale forma di sospensione invocando il prescritto del can. 223 § 2, che consente di limitare l’esercizio dei diritti dei fedeli per tutelare il bene comune. Tuttavia, è importante sottolineare che questo disposto ha natura generale, non potendo dunque costituire base di per sé sufficiente per limitazioni gravi e personali come quelle relative alla fattispecie in esame, laddove quindi l’applicazione della norma risulti slegata da esigenze concrete e accertamenti adeguati.
I criteri di distinzione della sospensione amministrativa da quella penale
Viene in ausilio nell’attività di qualificazione giuridica delle sospensioni la nota sentenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica coram Grocholewski, del 28 aprile 2007, nella quale vengono indicati i seguenti criteri fondamentali che orientano proprio il discrimen tra sospensione penale e amministrativa:
- in primo luogo occorre valutare la causa motiva del provvedimento, verificando se essa sia connessa alla contestazione di un delitto o a diverse esigenze di natura prudenziale;
- in continuità con il primo criterio, vanno poi indagate le finalità che l’autorità intende perseguire con il provvedimento in questione, se quelle tipiche delle sanzioni penali oppure, più in generale, di salvaguardia del bene comune e/o della stessa persona del chierico, casi questi ultimi che renderebbero legittima una sospensione di natura amministrativa;
- si aggiunge poi un’indagine circa la procedura adottata, per individuarne il connotato eminentemente penale o propriamente amministrativo.
Ulteriore profili rilevanti attengono poi al dato temporale, dal momento che una sospensione perpetua o a tempo indeterminato può essere sintomatica della natura sostanzialmente penale del provvedimento, e a quello del contesto in cui si inserisce la decisione, per verificare se vi siano profili di correlazione tra la stessa e la contestazione di atti delittuosi.
Di crescente rilevanza nella prassi è inoltre la valutazione circa la proporzionalità dell’atto, da intendersi non solo in termini di gradualità tra fatto e provvedimento, ma anche con riferimento al contenuto della decisione amministrativa; infatti, rappresenterebbe violazione di legge in decernendo comminare, al di fuori dei procedimenti criminali, provvedimenti di indole sostanzialmente penale-sanzionatoria. Dunque, un atto di sospensione che si presenti come definitivo o sproporzionato rispetto alle cause che lo hanno fatto sorgere e ai fini che si propone di perseguire potrebbe far sorgere il legittimo sospetto di trovarsi di fronte a un surrogato improprio della pena canonica.
Le conseguenze dell’illegittimità
Una sospensione amministrativa adottata in violazione dei principi sopra ricordati può essere oggetto di ricorso gerarchico (cann. 1732-1739) per tutti i gradi della giustizia amministrativa, sino, se del caso, al giudizio contenzioso dinanzi alla Segnatura Apostolica, per violazione di legge in decernendo. Infatti, la comminazione di una sanzione penale sotto le vesti di provvedimento amministrativo, ossia al di fuori dell’ambito di accertamento del delitto contestato, rappresenta valido motivo di impugnativa del provvedimento stesso. Sussisterebbe infatti il rischio evidente per il chierico di subire non solo le conseguenze pregiudizievoli di una decisione sproporzionatamente gravosa, ma anche violativa dell’intangibile diritto di difesa, riconosciuto in ogni procedimento penale.
Conclusioni
Alla luce di quanto sino ad ora esposto sul tema, ancorchè nei suoi tratti essenziali, la sospensione amministrativa delle facoltà ministeriali, quale fattispecie atipica e non regolata da un canone specifico, richiede grande cautela e rigore giuridico nella sua applicazione. Sebbene essa rappresenti un valido strumento rimesso nelle mani dell’Autorità amministrativa per far fronte a delicate esigenze correlate alla retta amministrazione della giustizia, la medesima non può certamente essere utilizzata per eludere i vincoli procedurali del diritto penale canonico, né per sostituire sanzioni che non potrebbero essere irrogate per mancanza dei presupposti legali. È dunque rimesso al prudente apprezzamento della Autorità l’indagine accurata circa le motivazioni reali che rendano giusto e proporzionato l’atto di sospensione, e ciò nell’obiettivo principale di preservare il retto funzionamento del governo ecclesiale.
Bibliografia
G. Paolo Montini, Il principio di proporzionalità nei provvedimenti di sospensione dall’esercizio del ministero sacerdotale secondo la Giurisprudenza della Segnatura Apostolica, in Periodica 109 (2020), pp. 313-364.
U. Rhode, La sospensione imposta di carattere non penale, in Periodica 109 (2020), pp. 273-312.
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, sent. definitiva coram Grocholewski 28 aprile 2007 – Prot. n. 37937/05 CA, in Ius Ecclesiae 19 (2007), con commento a cura di D. Cito, pp. 611-626.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA