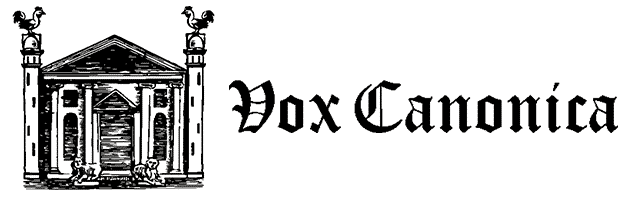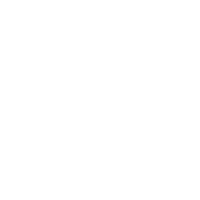La nuova Ratio Nationalis per la formazione presbiterale
Lo scorso gennaio è stata pubblicata la quarta edizione del documento La formazione dei presbiteri nelle Chiese in Italia. Orientamenti e norme per i seminari: si tratta della Ratio Nationalis, che adatta al contesto italiano la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, approvata nel 2016 dalla Congregazione (ora, Dicastero) per il Clero.
Sono stati necessari quasi nove anni per giungere a un documento che fosse in grado di declinare le innovazioni introdotte dalla Santa Sede nella cultura del nostro Paese, senza, però, perdere di vista il senso di universalità e cattolicità della figura del presbitero. Con la conferma della Santa Sede – prevista dalla nuova formulazione del can. 242 §1 CIC, successiva al m.p. Competentias quasdam decernere – la Ratio Nationalis entra in vigore ad experimentum per tre anni.
Con questa riforma, la CEI ha voluto sottolineare la progressività del cammino verso l’ordinazione presbiterale e, pertanto, ha delineato con precisione le tappe propedeutica, discepolare, configuratrice e di sintesi vocazionale introdotte dai §§57-79 RF.
La nuova fase propedeutica, tra conoscenza di sé, discernimento e cultura cristiana
Adesso, la fase propedeutica è un prerequisito per l’ammissione al Seminario maggiore, esteso anche a quanti provengono dal Seminario minore e da altre comunità vocazionali (§26 FP). Ha una durata compresa tra uno e due anni e deve realizzarsi in una comunità distinta e con responsabili differenti da quelli del Seminario maggiore.
Tenuto conto del clima di forte secolarizzazione e di confusione sull’identità cristiana, i vescovi italiani hanno voluto che, in questa fase, gli aspiranti perfezionino il proprio discernimento e riscoprano la ricchezza della chiamata battesimale, fondamento e origine di ogni altra vocazione.
Pertanto, si propone la conoscenza approfondita del Catechismo della Chiesa Cattolica, di testi filosofici e teologici, ma anche di classici della letteratura, al fine di avvicinarsi gradatamente al patrimonio culturale nel quale la cristianità si è sviluppata.
Le fasi discepolare e configuratrice, tra studio, missione e servizio
L’ingresso Seminario apre la fase discepolare, tempo in cui si presume la maturità di fede, sia sul versante della percezione della chiamata divina alla missione del presbitero, sia su quello della saldezza psicoaffettiva, necessaria all’orientamento celibatario, inteso non in senso egoistico, ma di totale dono di sé (§40 FP). Ha durata biennale e prevede il compimento degli studi filosofici (§§51-52 FP).
È in questo momento che devono trovare piena risoluzione, accertata mediante un dialogo sincero coi formatori, le eventuali tensioni che possono albergare nella sfera personale, non esclusa quella sessuale. A tal proposito, il §44 FP ribadisce, in piena adesione alla Ratio Fundamentalis, ma con un approccio volto al rispetto della persona nella sua globalità, l’incompatibilità con la vocazione presbiterale di pratiche omoaffettive o di tendenze radicate dello stesso tipo, nonché del sostegno alla cultura omosessuale.
La tappa configuratrice è pensata come un quadriennio nel quale sono compiuti gli studi teologici, ma anche, e soprattutto, l’inserimento del seminarista nella Chiesa locale, in cui sarà incardinato in futuro (§54 FP). Si prevede un anno di esperienza pastorale, caritativa e missionaria, di regola coincidente con il periodo immediatamente successivo alla fase discepolare.
Per sottolineare l’indole battesimale dei ministeri del lettorato e dell’accolitato e superare la loro concezione di cursus honorum, si prevede che il rito di istituzione coinvolga nella medesima celebrazione sia quanti si avviano verso il sacerdozio, sia gli altri laici. Con l’ordinazione diaconale, la fase si conclude, dal momento che il chierico viene configurato definitivamente come Cristo servo di tutti.
Dal diaconato al presbiterato al dono di sé nella Chiesa particolare
Il diacono transeunte, infine, uscirà dal microcosmo del seminario per aprirsi a una tappa, quella di sintesi vocazionale, di attività a servizio della comunità, scelta dal Vescovo con l’ausilio dei formatori. Al termine dell’anno “di sintesi”, il diacono riceverà l’ordinazione presbiterale.
È interessante notare che FB cerca di mantenere i legami con la comunità seminaristica: si consiglia, infatti, all’Ordinario di confrontarsi con il Rettore prima della destinazione dei novelli sacerdoti, con l’obiettivo di selezionare gli ambienti più adatti per l’armonico sviluppo del ministro sacro (§63 FP).
Una profonda sensibilità sinodale è auspicata nei processi decisionali: ad ogni passaggio che comporta una valutazione sull’idoneità del candidato, il Rettore ha l’obbligo di chiedere il parere dei propri collaboratori, dei docenti, dei parroci che hanno accolto il seminarista. La pluralità di voci è raggiunta grazie all’apporto di figure femminili, chiamate a dare il loro apporto valutativo (§§67-68 FP).
È da valutare positivamente, infine, la sottolineatura sulla pubblicità e sulla trasparenza sui motivi degli atti riguardanti la vita seminaristica, soprattutto quelli che possono avere un impatto pregiudizievole (§71 FP).
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA