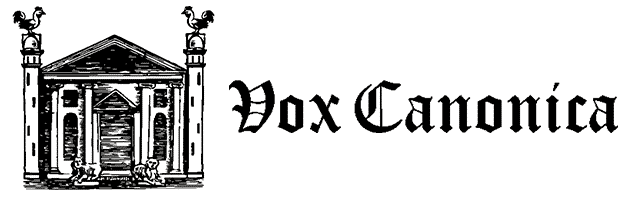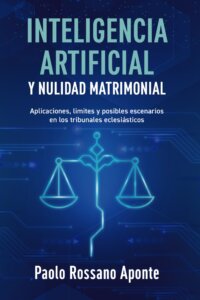Le particolarità del diritto penale canonico
La tutela penale messa in atto dal diritto canonico possiede delle specifiche particolarità, propriamente ecclesiali, che la caratterizzano. La prima peculiarità che viene nettamente in rilievo è la circostanza nella quale viene fatto uso della pena canonica, ovvero unicamente nel caso in cui le finalità che si mira ad ottenere non possano essere raggiunte mediante altre vie, ovvero mediante altri mezzi ecclesiali, non penali. E’ essenziale dunque che l’azione penale venga intrapresa unicamente come extrema ratio. Tale concetto viene espresso chiaramente nel canone 1341 CIC/1983.
Dalla situazione deve dunque emergere una spiccata necessità della pena per tutelare la Chiesa lì dove altri mezzi hanno fallito e non si siano dimostrati sufficienti per poter raggiungere la riparazione delle scandalo, il ristabilimento della giustizia, né l’emendamento del reo [1]. La seconda peculiarità propria di questo diritto si evince sia dal sovra citato canone 1341 che dal canone 1344 CIC/1983, nei quali emerge una forte preponderanza di mitezza e misericordia nell’applicazione delle pene canoniche [2]. Naturalmente la misericordia non è una prerogativa puramente ecclesiale, essendo presente anche nell’ambito penale secolare, tuttavia è innegabile ed anche piuttosto apparente che la presenza della misericordia sia più marcata nell’ambito dell’applicazione delle sanzioni penali canoniche. C. J. Errázuriz trova una ragione giustificativa per tale fenomeno, ritenendo che:
“in virtù dell’esistenza di altre vie per raggiungere le finalità della pena, quest’ultima perda l’inesorabilità che possiede in ambito secolare, per cui la reazione ecclesiale dinanzi al delitto non è primariamente penale.” [3]
La misericordia nell’applicazione e determinazione della pena
In ambito ecclesiale non vige dunque un applicazione inesorabile di pene proporzionatamente gravi alla gravità del danno arrecato e dello scandalo causato, bensì vi è spazio per un contemperamento e per la valutazione di elementi ulteriori oltre a ciò, tale da evitare l’applicazione di un arcaica legge del taglione quale era quella dell’ “occhio per occhio”. E’ importante tenere dunque a mente che:
“l’applicazione delle pene non implica escludere, anzi richiede ancor più catturare vie ispirate dalla misericordia che tendano a favorire la sua (del fedele delinquente) vita cristiana e il suo senso di appartenenza alla comunità ecclesiale.” [4]
Si potrebbe dunque intendere un’estensione o meglio un’attuazione di questa stessa misericordia. L’istituto specifico del diritto penale canonico, della iusta poena, recentemente modificato a seguito della revisione del Libro VI del Codice di diritto canonico della Chiesa latina, disposta da Papa Francesco mediante la Costituzione Apostolica, Pascite gregem Dei, il 23 maggio 2021. La prima domanda che diviene fondamentale porsi in questo frangente riguarda il motivo dell’esistenza di questa tipologia di pena nell’ambito del diritto penale canonico.
L’obiettivo della riforma del 2021 era infatti quello di garantire una più precisa determinazione delle pene, il che avrebbe dovuto comportare, a rigor di logica, la rimozione di tutte le pene indeterminate. Nonostante ciò le pene indeterminate sono riuscite ad imporsi anche a seguito di quest’importante opera di riduzione e nel Codice attuale sono presenti in svariati canoni, seppur con una definizione diversa e più specifica delle sanzioni che si devono applicare. Monsignor M. Graulich a tal riguardo affermò che:
“Per raggiungere il suo scopo la riforma doveva semplificare l’applicazione del diritto penale, eliminando l’insicurezza che si era creata a causa delle formulazioni indeterminate contenute nella legislazione antecedente. Di conseguenza, anziché parlare della necessità di applicare una giusta pena (iusta poena puniatur), si rimanda adesso all’applicazione delle pene previste nei can. 1336 §§2-4.” [5]
Le perplessità e le critiche circa la iusta poena
Nonostante i tentativi di miglior definizione delle pene, vi sono attualmente ancora ventidue canoni in cui ricorre l’espressione iusta poena ed anche altri casi in cui si fa espresso riferimento alle pene indeterminate mediante l’impiego della formula “pro delicti gravitate” [6]. Nonostante le critiche rivolte in passato a questa definizione, ritenendo l’aggettivo “iusta” superfluo e presupposto nello stesso concetto di pena canonica, e nonostante le perplessità espresse circa i pericoli che avrebbe comportato una non esatta definizione della pena, quali la scarsa forza dissuasoria e l’ampio potere discrezionale del giudice [7], questa tipologia di pena venne giustamente mantenuta. Ma per quale ragione?
L’utilità della giusta pena
Essendo una pena indeterminata, la giusta pena potrebbe apparire diametralmente opposta alle esigenze del diritto penale, che richiedono una definizione precisa ed il più possibile dettagliata, ma in realtà così non è. Essa infatti regala una particolare attenzione al reo, alla sua conversione ed al ristabilimento della giustizia. Il Codice del 1917 impiegava la terminologia “congrua pena” facendo con essa riferimento alla pena che più si confaceva a quel caso in concreto, ovvero alla pena che era adatta, congrua appunto. Nel Codice attuale il termine “congrua poena” venne sostituito con quello di “iusta poena”.
Questa nuova accezione intendeva esprimere un ricorso alla pena attentamente misurato, che non sarebbe mai dovuto essere frutto dell’applicazione di un potere discrezionale. Per tale ragione la formula “prudenti arbitrio iudicis vel superioris” contenuta nel Codice del 1917 venne sostituita con le parole “prudenti iudicis aestimationi“. L’obiettivo di questa sostituzione del termine arbitrio con aestimatio era quello di fugare ogni dubbio circa una possibile discrezionalità del giudice nella decisione della pena da applicare [8]. La correttezza e la giustizia devono dunque guidare il giudice nella determinazione di tali pene indeterminate. Secondo E. Miragoli il termine “giusta pena” sarebbe in grado di
“evocare – e contemperare – le esigenze di giustizia ed equità, la necessità della espiazione e la preoccupazione di ricondurre il reo sulla giusta strada, la conversione, e il dovere di riparare il danno arrecato alla comunità” [9].
Il principio di sussidiarietà
Se, nonostante l’obiettivo che era stato prefissato con la riforma del 2021, questa forma di sanzione viene ancora prevista nel Codice attuale in misura importante deve esserci una buona ragione. Innanzitutto non si è voluto rinunciare al principio di sussidiarietà stabilito nel canone 1315 §2, 3° CIC/1983. Tale principio è intimamente legato al concetto di giusta pena e profondamente radicato nella tradizione canonica, dato che il giudice canonico ha la necessità di disporre di una discreta libertà per poter valutare l’applicazione della pena nel caso concreto. Nel diritto canonico non vengono dunque determinate in modo rigido e tassativo le specifiche pene da applicare per ogni delitto, ed in ciò consiste il suo pregio, dato che in tal modo viene privilegiato il bene del singolo rispetto all’applicazione di una normativa giuridica uniforme [10].
I limiti che si devono osservare nella determinazione della pena indeterminata
Le pene indeterminate non possono applicare pene più gravi, in particolar modo le censure e le pene perpetue. Tuttavia il divieto di applicare sanzioni particolarmente gravi viene meno se lo richiede la gravitas casus. Ma per valutare in concreto la gravità del caso vanno presi in considerazione una serie di elementi, tra cui: gli elementi oggettivi del delitto (circostanze, mezzi) e quelli soggettivi (l’imputabilità) [11]. La gravità del caso deve dunque necessariamente sussistere affinché si possa pensare di applicare una pena più grave.
La proporzione è la chiave della giusta pena
La valutazione che il giudice deve intraprendere è complessa e delicata, in modo da far sì di mantenere l’equilibrio tra l’adeguatezza della pena e la gravità del delitto commesso. Egli dovrà dunque soppesare l’imputabilità, l’oggetto e la gravità della legge violata, oltre alle circostanze relative alla persona e al compimento del delitto, lo scandalo ed il danno arrecato. Il primo passo di questo procedimento sarà accertare che vi sia stata un violazione deliberata della legge, che potrà essere gravemente imputata per dolo o per colpa ad un determinato soggetto. Dopo di che il delitto commesso verrà preso in considerazione sia dal punto di vista dell’oggetto della legge, che dal punto di vista della gravità della legge violata. Inoltre non si sorvola sugli effetti negativi del delitto che si ripercuotono sui terzi, ovvero tutto ciò che potrebbe costituire danno o scandalo.
Il revisionato canone 1349 CIC/1983 pone il focus proprio su questa proporzione tra dimensione della pena e dimensione del danno e dello scandalo, quale offesa del vincolo che unisce la Chiesa [12], arrecato [13]. Nell’applicare la giusta pena non ci si attiene dunque unicamente ai criteri che utilizzano tutti gli ordinamenti giuridici per determinare una sanzione, bensì si devono tenere in considerazione le peculiarità che sono proprie della pena canonica, ovvero la tipologia di pena, essendo essa una pena spirituale, la finalità che la pena persegue, ovvero la conversione del reo e la riparazione del danno, ed il metodo che impiega per ottenerla, ovvero la limitazione dell’esercizio di alcuni diritti propri dei crhistifideles [13]. Ritengo dunque che le parole utilizzate da M. Miragoli per descrivere la “pena giusta” riassumano perfettamente l’intrinseco significato di questa forma di sanzione:
“proporzionata al delitto, tiene conto delle circostanze, non perde di vista la finalità ultima del diritto penale e del diritto in generale…” [14]
Note
- Cfr. C. J. ERRÁZURIZ, La tutela penale dei beni giuridici nella Chiesa: tra esigenze comuni con l’ambito secolare e caratteristiche ecclesiali proprie, in AA. VV., Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana, Città del Vaticano, 2023, pp. 51-71: 67.
- Cfr. A. D’AURIA, Diritto penale, conversione e bene ecclesiale, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (ed.), Il diritto penale al servizio, p. 57.
- C. J. ERRÁZURIZ, La tutela penale dei beni giuridici nella Chiesa: tra esigenze comuni con l’ambito secolare e caratteristiche ecclesiali proprie, in AA. VV., Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana, Città del Vaticano, 2023, cit., pp. 51-71: 68-69.
- C. J. ERRÁZURIZ, La tutela penale dei beni giuridici nella Chiesa: tra esigenze comuni con l’ambito secolare e caratteristiche ecclesiali proprie, in AA. VV., Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana, Città del Vaticano, 2023, cit., pp. 51-71: 71.
- M. GRAULICH, “Ut pastores haberent agile instrumentum salutare et ad corrigenda aptum”: alcune modifiche nella definizione delle sanzioni penali nella rinnovata disciplina penale canonica, in Quaderni di diritto ecclesiale 35 (2022), cit., p. 290.
- Cfr. M. MOSCONI, La indeterminatezza della iusta poena nel libro VI, in AA. VV., Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana, Città del Vaticano, 2023, pp. 117-136: 119-121.
- Ibid., pp. 122-124.
- Ibid., pp. 121-123.
- E. MIRAGOLI, La “pena giusta” nei casi di delicta graviora, in Quaderni di diritto ecclesiale 25 (2012), pp. 358-359.
- Cfr. M. MOSCONI, La indeterminatezza della iusta poena nel libro VI, in AA. VV., Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana, Città del Vaticano, 2023, pp. 117-136: 125-127.
- Cfr. C. PAPALE, Pene indeterminate, in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (ed.), Diccionario general de derecho canónico, p. 80.
- Cfr. D. G. ASTIGUETA, La pena come sanzione: un contributo su questo concetto, in Periodica de re canonica 101 (2012), p. 516.
- Cfr. M. MOSCONI, La indeterminatezza della iusta poena nel libro VI, in AA. VV., Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana, Città del Vaticano, 2023, pp. 117-136: 132-134.
- Cfr. M. MOSCONI, La condizione canonica del fedele incorso nelle sanzioni penali, in Quaderni di diritto ecclesiale 12 (1999), p. 189.
- E. MIRAGOLI, La “pena giusta” nei casi di delicta graviora, in Quaderni di diritto ecclesiale 25 (2012), cit., p. 366.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”
(San Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA