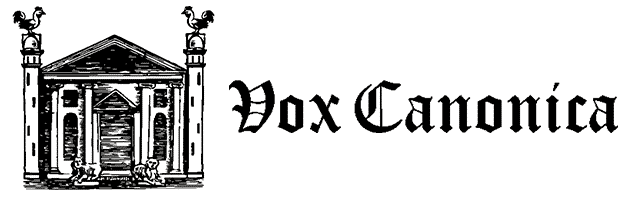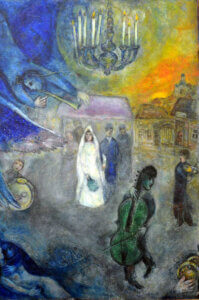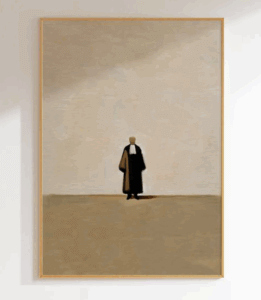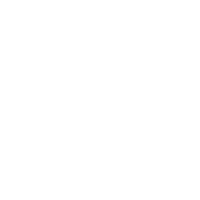Marc Chagall, le luci del matrimonio, olio su tela, 1945, Kunsthaus, Zurigo
Introduzione
L’aumento delle cause di nullità matrimoniale nei tribunali ecclesiastici negli ultimi decenni ha messo in evidenza una crescente difficoltà, da parte dei nubendi, nel comprendere e vivere pienamente il matrimonio secondo la visione canonica. L’antropologia odierna, fortemente individualista e affettivamente instabile, alimenta l’incapacità matrimoniale. La cultura della provvisorietà, la paura dell’impegno, la fragilità emotiva e l’incapacità di gestione del conflitto minano la maturità necessaria per il consenso matrimoniale. L’“analfabetismo affettivo” è una condizione spesso rilevata dai periti psicologi e psichiatri nei processi canonici: soggetti cresciuti in ambienti disfunzionali, iperprotetti o iperliberisti, non hanno mai appreso la dinamica del dono di sé e del sacrificio reciproco, essenziale per la vita coniugale. Inoltre, la diffusione dei social media e della cultura performativa ha creato un’immagine idealizzata del matrimonio, basata più sull’apparenza che sulla sostanza, generando illusioni affettive che si infrangono presto nella realtà.
Nei processi di nullità, i vizi del consenso più frequentemente invocati riguardano l’incapacità (can. 1095, nn. 2 e 3 CIC) e la simulazione del consenso (can. 1101 §2 CIC), sia essa totale o parziale. L’incidenza di questi vizi rispecchia l’evoluzione culturale della società contemporanea, sempre più segnata da una visione individualistica, instabile e spesso relativista dell’impegno coniugale. Tale contesto favorisce l’insorgenza di condizioni soggettive di incapacità o l’intenzione positiva di escludere elementi o proprietà essenziali del matrimonio, come l’indissolubilità, la fedeltà e la procreazione.
Il matrimonio vissuto nell’ignoranza del suo significato
Un elemento sempre più rilevante nella trattazione della nullità matrimoniale è la mancanza di conoscenza da parte dei nubendi circa le caratteristiche e le implicazioni del matrimonio canonico. Molti sposi, pur scegliendo il rito religioso, lo fanno spesso per motivi culturali, estetici o sociali, senza una reale comprensione della sua natura sacramentale e delle sue proprietà essenziali: l’unità, l’indissolubilità, l’apertura alla procreazione e l’orientamento al bene dei coniugi.
In tal senso, si segnala come l’esclusione dell’indissolubilità sia spesso generata da una mentalità divorzista ormai radicata, favorita dalla mancata conoscenza del diritto canonico e del valore giuridico del vincolo coniugale [1]. Non meno frequente è la compromissione del bonum fidei, a causa di una visione relativista e fluida della fedeltà coniugale, o l’esclusione del bonum prolis, in nome di una progettualità familiare fondata sull’autorealizzazione e sul rifiuto della genitorialità. Dall’analisi della giurisprudenza dal 2010 al 2022, edita e inedita, non emerge alcuna sentenza, almeno fino al 2017, che tratti dell’influsso della mentalità contemporanea circa l’incapacitas assumendi (can. 1095 n. 3); diversamente si deve dire, invece, nei confronti della simulazione, in particolare per quanto riguarda l’esclusione dell’indissolubilità [2]
Simulazione del consenso (can. 1101 §2) e tria bona
Il can. 1101 §2 del Codice di Diritto Canonico stabilisce che, qualora uno o entrambi i contraenti escludano, mediante un atto positivo della volontà, il matrimonio stesso o uno dei suoi elementi o proprietà essenziali, il consenso è da ritenersi invalido, e il matrimonio pertanto nullo per simulazione. Tale simulazione può assumere diverse configurazioni giuridiche. Essa può essere bilaterale, quando i nubendi, di comune accordo, decidono di esprimere un consenso meramente apparente, escludendo entrambi la realtà del vincolo coniugale; oppure unilaterale, quando solo uno dei due esclude positivamente il matrimonio, un suo elemento o una sua proprietà essenziale, senza che l’altro ne sia a conoscenza.
Sotto il profilo dell’oggetto escluso, la simulazione può essere totale, qualora venga escluso il matrimonio in sé, ad esempio quando la celebrazione è perseguita per finalità estranee all’istituto matrimoniale, come l’acquisizione della cittadinanza o benefici patrimoniali; oppure parziale, quando viene escluso uno o più elementi (can. 1055 §1) o proprietà essenziali del matrimonio (can. 1056), pur volendo contrarre matrimonio in senso generico [3]. Tra le ipotesi di simulazione rientra anzitutto l’esclusione del matrimonio in sé (simulazione totale), che si verifica quando uno dei contraenti non riconosce valore giuridico o personale al patto coniugale, considerandolo una mera formalità esteriore, priva di volontà effettiva di contrarre il vincolo.
L’esclusione della prole (bonum prolis), si configura quando uno o entrambi i nubendi, mediante atto positivo della volontà, rifiutano in modo definitivo o condizionato l’apertura alla generazione della prole. Tale volontà può manifestarsi attraverso il rifiuto assoluto degli atti coniugali, la loro limitazione ai soli periodi di infertilità o il ricorso sistematico a metodi anticoncezionali [4]. L’esclusione può essere perpetua, laddove la prole sia percepita come ostacolo, ad esempio, alle aspirazioni personali come quelle lavorative oppure temporanea, subordinata a eventi futuri e incerti.
L’esclusione dell’indissolubilità (bonum sacramenti), si verifica quando uno dei nubendi non intende vincolarsi in modo permanente, riservandosi la facoltà di ricorrere al divorzio qualora l’unione coniugale risultasse insoddisfacente o fallisse [5]. L’esclusione della fedeltà (bonum fidei) si ha quando uno dei contraenti esclude, in modo cosciente e deliberato, l’obbligo dell’esclusività coniugale, riservandosi il diritto a relazioni extraconiugali, negando così al coniuge il diritto all’intimità esclusiva [6]. L’esclusione del bene dei coniugi (bonum coniugum), si riscontra qualora uno dei nubendi non intenda instaurare una comunione di vita affettiva e relazionale fondata sulla reciproca donazione, accoglienza e sostegno. Tale ipotesi è frequentemente riconducibile a soggetti affetti da tratti di personalità fortemente egocentrici, asociali, narcisisti o con tendenze aggressive, tali da rendere impossibile la realizzazione del fine umano e spirituale del matrimonio [7].
Infine, l’esclusione della sacramentalità si realizza quando, pur essendo battezzato, il contraente celebra il matrimonio in forma canonica unicamente per motivi di convenienza sociale, pressioni familiari o per esigenze esterne, senza alcuna intenzione di contrarre il sacramento, ossia senza riconoscere alla celebrazione alcun valore spirituale o soprannaturale.
Il matrimonio come vocazione: una scelta consapevole e libera
Nel cuore della riflessione canonico-pastorale sul matrimonio emerge un dato teologico e antropologico imprescindibile: il matrimonio è una vocazione divina. Non si tratta di una mera tappa della vita umana né di un contratto sociale, ma di una chiamata da parte di Dio, che invita a vivere una comunione di amore totale, fedele, feconda e indissolubile, fondato in Cristo.
Questa concezione è ampiamente sostenuta dal Magistero della Chiesa. San Giovanni Paolo II, nell’esortazione apostolica Familiaris consortio (n. 11), sottolinea che il matrimonio «non è il risultato casuale o forzato di particolari situazioni culturali o sociologiche, ma è una realtà voluta e creata da Dio stesso». Allo stesso modo, Papa Francesco, nell’esortazione Amoris laetitia (n. 72), afferma che «il matrimonio cristiano è una vocazione che si accoglie con una decisione ponderata e libera».
In questo contesto, la cultura contemporanea, caratterizzata da individualismo, relativismo etico, provvisorietà degli impegni, libertà intesa come autosufficienza, ed emotività come criterio esclusivo di scelta, pone ostacoli significativi per il riconoscimento e l’assunzione della vocazione matrimoniale autentica. In particolare, non è raro che alcuni si accostino al matrimonio sacramentale senza una vera vocazione, motivati da pressioni familiari, convenzioni sociali, desiderio di autorealizzazione o attrazione sentimentale. Tuttavia, il matrimonio non è un obbligo sociale né un diritto da esercitare a prescindere; se non si ha una chiara consapevolezza della chiamata divina al matrimonio cristiano, è meglio non sposarsi. Come per il sacerdozio, anche per il matrimonio vale il principio del discernimento: è preferibile un celibato maturo e coerente a un matrimonio nullo o fallimentare.
Linee preventive e pastorali
Alla luce di quanto esposto, emerge con urgenza la necessità di un intervento preventivo nella formazione delle coscienze. Le soluzioni a tale problematica non devono limitarsi alla sola dimensione giuridica, ma devono abbracciare un approccio che includa aspetti pastorali, educativi e formativi. Formazione Remota e Prossima al Matrimonio: la preparazione dei nubendi deve andare oltre incontri prematrimoniali superficiali e di breve durata. Essa deve evolversi in un percorso formativo continuo, che favorisca una crescita sia spirituale che personale, centrata sulla fede e sulla maturità umana. Solo così i coniugi potranno comprendere pienamente l’impegno che assumono e le responsabilità matrimoniali che li attendono. Discernimento Vocazionale: un autentico discernimento vocazionale è essenziale per aiutare i giovani a riflettere sulla loro attitudine alla vita coniugale e a verificare se possiedono le intenzioni e le disposizioni necessarie per rispondere alla chiamata al matrimonio, un impegno che comporta totalità, fedeltà e indissolubilità.
Accompagnamento Post-Matrimoniale: un cammino di accompagnamento che si estenda oltre la celebrazione del matrimonio è fondamentale, soprattutto nei primi anni, che sono i più fragili e delicati. Tale accompagnamento è decisivo per sostenere i coniugi nell’affrontare le difficoltà iniziali e per radicare la loro unione nella fede e nella vita cristiana, evitando crisi che potrebbero compromettere la stabilità del matrimonio. Integrazione della Dimensione Giuridica nella Pastorale: è cruciale che i pastori siano formati non solo sulle dimensioni teologiche del matrimonio, ma anche sui criteri di validità del consenso matrimoniale, affinché possano cogliere segnali di allarme che potrebbero indicare una potenziale invalidità del matrimonio. Una preparazione adeguata aiuterà a garantire che i nubendi siano pienamente consapevoli delle implicazioni giuridiche e teologiche del loro impegno.
Conclusione
L’aumento delle nullità matrimoniali non è solo un dato statistico, ma il riflesso di una profonda crisi antropologica e relazionale. Il diritto canonico, con la sua attenzione alla verità del consenso e alla dignità della persona, offre criteri chiari per discernere la validità del matrimonio, ma è la pastorale, nelle sue varie forme, a dover prevenire tali situazioni, formando coscienze mature, affetti stabili e scelte vocazionali autentiche. In questo processo, giustizia e misericordia si incontrano: la Chiesa non si limita a dichiarare nulli matrimoni che non sono mai esistiti, ma si impegna affinché ogni matrimonio che nasce sia fondato sulla verità, sulla libertà e sulla piena capacità di donarsi, garantendo così la solidità e la sacralità del vincolo coniugale.
Note
[1] cfr. coram Ewers, decisio diei 1981, RRDec., LXXIII, p. 364, n. 6; coram Ragni, sent. diei 16 decembris 1986, RRDec., LXXVIII, p. 715, n. 4]
[2] cfr. D. Salvatori, L’incapacità di assumere gli oneri coniugali: aspetti giuridico-giurisprudenziali in Aa. VV.,Incapacità matrimoniale e società moderna. Atti degli incontri di formazione presso il Tribunale di Prima Istanza del Vicariato di Roma in collaborazione con il Coetus Advocatorum, LEV, Città del Vaticano, 2023, p. 56.
[3] cfr. coram Staffa, decisio diei 21 maii 1948, RRDec., vol. XL, p. 186, n. 2.
[4] cfr. coram Anné, decisio diei 11 iulii 1972, RRDec., vol. LXIV, p. 432, n. 3; coram Jaeger, sentenza dell’8 luglio 2015, A. 154/2015, n. 11.
[5] cfr. coram Funghini, sent. diei 25 aprilis 1990, RRDec., vol. LXXXII, p. 297, n. 3.
[6] cfr. coram Pompedda, decisio diei 26 novembris 1993, RRDec., vol. LXXXV, p. 719, n.6.
[7] interessante anche notare la correlazione tra l’incapacità di assumere gli oneri coniugali e bonum coniugum, cfr. coram Arokiaraj, sentenza del 17 febbraio 2021, Opolien., A. 22/2021.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA