Mariangela Cacace, olio e tecnica mista su tela, mostra “Coesioni” alla Catania art gallery
Nel linguaggio giuridico il termine corpus non è un semplice sinonimo di raccolta, ma indica un insieme completo e riconosciuto di testi con valore normativo. Così come Giustiniano aveva fatto con il Corpus Iuris Civilis, anche la Chiesa costruì nel tempo un proprio Corpus Iuris Canonici, che riuniva il Decretum Gratiani, il Liber Extra di Gregorio IX, il Liber Sextus di Bonifacio VIII, le Clementinae di Clemente V e le Extravagantes QUI per approfondire. Non era solo un titolo: rappresentava l’ambizione di offrire al diritto canonico una forma organica e coerente, in linea con lo spirito del Rinascimento giuridico.
Il passo decisivo avvenne sotto il pontificato di Gregorio XIII. Con il breve Emendationem decretorum del 2 giugno 1582, il Papa approvò la cosiddetta editio Romana. Stampata a Roma nello stesso anno, essa raccoglieva in modo unitario e ufficiale l’intero Corpus Iuris Canonici: da un lato il Decretum Gratiani, emendato e arricchito di note, dall’altro il Liber Sextus di Bonifacio VIII, restituito insieme alle Clementinae e alle Extravagantes. Per la prima volta la Chiesa si trovava davanti a un testo unico e stabilizzato, destinato a diventare un punto di riferimento costante per secoli.
Dall’editio Romana alle raccolte della Curia
Un aspetto caratteristico dell’editio Romana fu la pubblicazione delle glossae a margine del testo. Fra tutte spiccava la glossa ordinaria, chiamata così perché universalmente accettata. Attorno al Decretum e alle Decretali non compariva solo la legge, ma anche la tradizione interpretativa che l’accompagnava. La stampa sanciva così un dato fondamentale: nel diritto canonico la norma non vive mai isolata, ma è sempre letta, commentata e resa viva dall’opera dei giuristi.
Dopo la pubblicazione del Corpus Iuris Canonici, non furono più redatte nuove collezioni con valore legislativo autentico. Questo non significò, però, la fine delle raccolte. Anzi, tra XVI e XIX secolo si moltiplicarono compilazioni private, spesso nate per esigenze pratiche, soprattutto in relazione all’attività della Curia Romana, che Sisto V aveva riorganizzato con la costituzione Immensa aeterni Dei del 1588.
I Bullaria raccolsero costituzioni e decretali pontificie; vennero pubblicati i canoni dei Concili, in particolare quelli del Concilio di Trento; e grande importanza ebbero le raccolte prodotte dalla Congregazione di Propaganda Fide, fondamentali per il lavoro missionario. Tra queste si ricordano i Canones et Decreta del 1834, l’Iuris Pontificii de Propaganda Fide del 1839-1841, il monumentale Ius Pontificium di R. De Martinis (1888-1897), le Collectanea del 1907 e la Sylloge del 1939.
Dal Codice del 1917 al Codice del 1983
La vera cesura si ebbe nel 1917, quando Benedetto XV promulgò il primo Codex Iuris Canonici. Per la prima volta il diritto della Chiesa veniva presentato in forma codificata, superando la stratificazione di testi e raccolte. Già da decenni, però, esisteva uno strumento ufficiale di promulgazione: gli Acta Sanctae Sedis (1865-1908, ufficiali dal 1904), sostituiti dal 1909 dagli Acta Apostolicae Sedis, che ancora oggi hanno valore autentico (cfr. can. 8 § 1 CIC/83).
Accanto agli atti ufficiali non mancarono raccolte private, pensate per studiosi e pratici del diritto: i Fontes del Codice curati dal cardinale Gasparri e dai suoi successori (1923-1939), l’Index verborum del 1941, l’Interpretatio di Regatillo (1953), fino all’Enchiridion canonicum di Sartori e Belluco (1963).
Il rinnovamento conciliare portò infine alla promulgazione del nuovo Codex Iuris Canonici nel 1983, sotto Giovanni Paolo II. Anche in questa fase si affiancarono raccolte private, divise principalmente tra documenti della Chiesa universale e legislazione complementare al Codice.
Dal Corpus Iuris Canonici del Rinascimento al Codice del 1983, il diritto della Chiesa ha conosciuto fasi diverse ma unite da un filo di continuità. Le collezioni ufficiali, come l’editio Romana di Gregorio XIII o i due Codici del 1917 e del 1983, hanno garantito stabilità e autorità normativa; accanto a esse, raccolte private e strumenti interpretativi hanno reso possibile la comprensione, la diffusione e l’applicazione concreta delle norme.
Ne emerge un tratto caratteristico del diritto canonico: non è mai stato solo un insieme di leggi promulgate dall’alto, ma un corpo vivo, accompagnato dall’opera di giuristi, teologi e istituzioni che lo hanno commentato e trasmesso. È proprio in questa dialettica tra norma e interpretazione che si riconosce la forza di una tradizione giuridica capace di rinnovarsi senza perdere le proprie radici.
Note
Corpus Iuris Canonici, ed. E. Friedberg, 2 voll., Lipsiae, 1879-1881 (rist. Graz, 1959).
P. Gasparri (a cura di), Codicis Iuris Canonici Fontes, voll. I-IX, Città del Vaticano, 1923-1939.
E.F. Regatillo, Interpretatio et iurisprudentia Codicis Iuris Canonici, Santander, 1953.
C. Sartori – B.I. Belluco, Enchiridion canonicum, Roma, 1963.
C. Fantappiè, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, Bologna, il Mulino, 2011.
W. Müller – M. Sommar, Il diritto canonico nella storia della Chiesa, Bologna, il Mulino, 2014.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
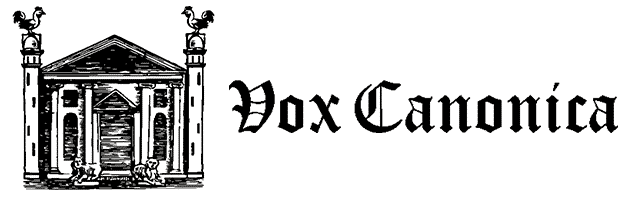

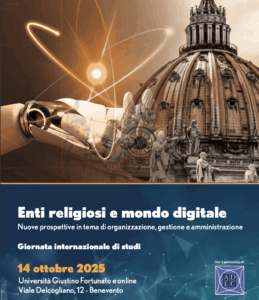
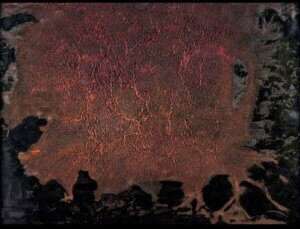
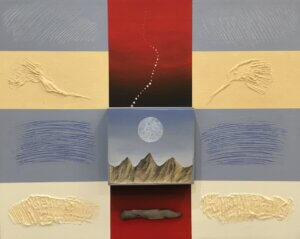
Una risposta
Questa autrice è sempre puntuale e impeccabile