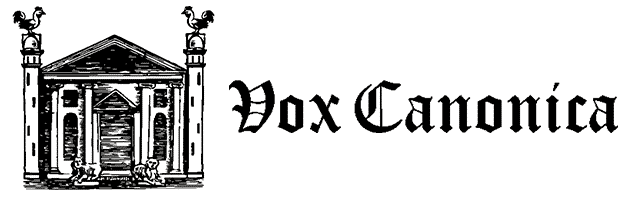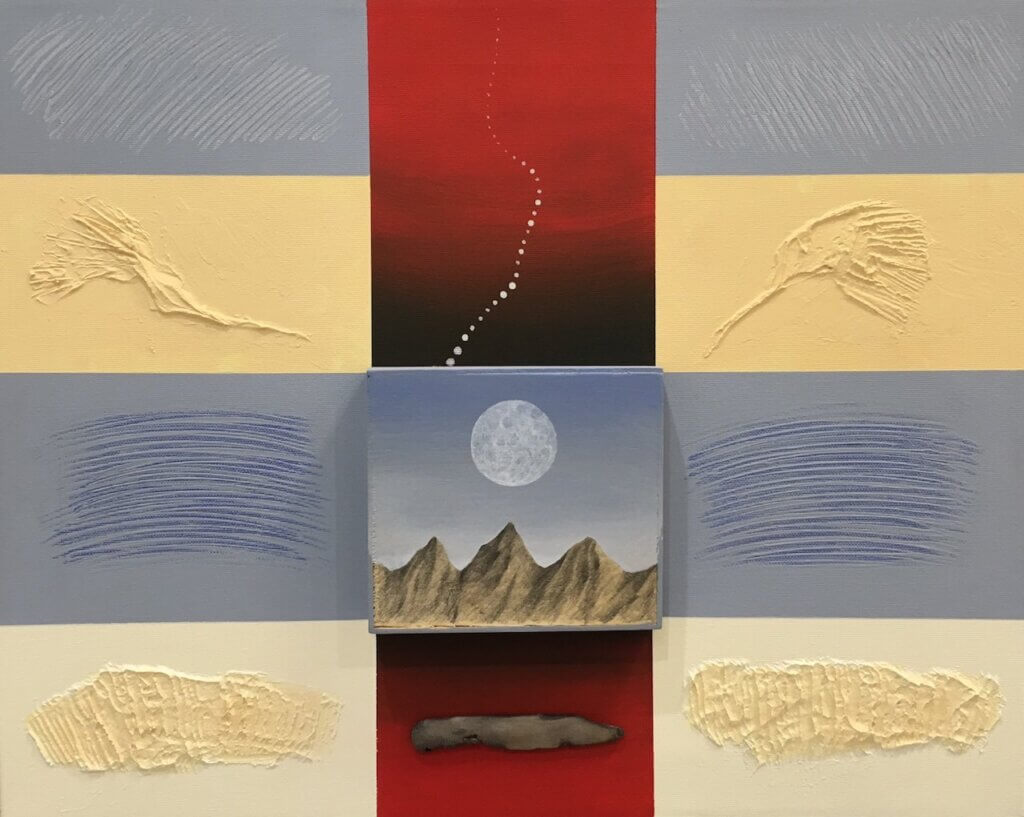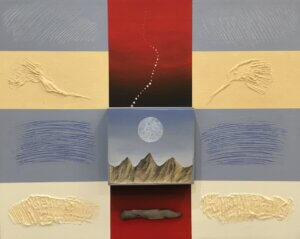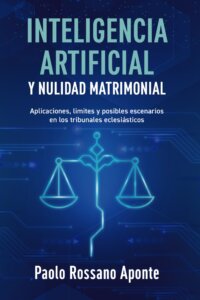Sergio Gioielli, paesaggio, tecnica mista su tela 50×40
L’ordinamento giuridico italiano in ossequio al principio costituzionale della libertà individuale, tutela penalmente quel particolare stato di fatto, per cui una notizia deve essere conosciuta solo da una persona o da una ristretta cerchia di persone, garantito dal diritto, che è il segreto professionale, di cui anche il sigillo sacramentale fa parte [1].
Chiariamo alcuni termini
Professione: va intesa in senso lato come applicazione continuata e caratteristica dell’attività della persona, non necessariamente per uno scopo di guadagno, ma comunque per un fine lecito, diretto a servizi personali o a prestazioni a favore dei richiedenti. Essa include l’idea di una situazione personale particolare nell’ambiente in cui si verifica l’esercizio professionale (Cfr. art. 622 c.p.) [2].
Status: con questo termine si fa riferimento «non soltanto alla titolarità e all’esercizio di una particolare attività professionale, ma anche a ogni altra speciale condizione giuridica personale, dipendente da determinate situazioni personali nell’ambiente in cui un esercizio professionale si svolge o è svolto» [3].
Ufficio: indica l’esercizio permanente o temporaneo, a titolo oneroso o gratuito, di speciali funzioni che pur non avendo natura professionale in senso stretto qualificano ugualmente la persona come oggetto di una particolare specie di attività sociale [4]. L’ufficio può essere privato o pubblico [5].
Tutela della libertà individuale
La tutela penale contro le condotte che violano il segreto professionale è riferita alla tutela della libertà individuale – il che spiega la perseguibilità a querela di parte dell’illecito [6] – a cui sono collegati interessi individuali finali e indirettamente tutelati di rilievo come: la salute, la difesa processuale, la libertà religiosa, affidati ai professionisti in senso lato.
La seconda tipologia di tutela è contenuta nell’art. 200 c.p.p. che stabilisce:
«Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria [331, 334]: i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano; […]».
L’art. 4 n. 4 dell’Accordo di Revisione del Concordato del 1929 statuisce: «Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero». Il CIC ’83 stabilisce l’esistenza nella Chiesa, per istituzione divina di «ministri sacri, che nel diritto sono chiamati anche chierici» (can. 207 § 1) e che si diventa chierici «con l’ordinazione diaconale» (can. 266 § 1). Il can. 1008 prevede infine: «Con il sacramento dell’ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri».
Nell’art. 4 n. 4 dell’Accordo, il termine “ecclesiastico” è rimasto invariato nelle diverse bozze di revisione. In alcune recenti intese stipulate dalla Santa Sede si parla espressamente di “confessione”, come distinta dalla “cura d’anime”, e si nota un tendenziale ampliamento del novero delle persone ricomprese nella categoria di “ecclesiastico”. Pertanto, si è propensi nel ritenere che l’art. 622 c.p. e la tutela dell’art. 200 c.p.p. siano da applicare non solo ai presbiteri e ai vescovi, ma anche ai diaconi e ai religiosi (uomini e donne).
Esenzione solo nell’ambito del sigillo
Tuttavia, mentre nel caso del sacerdote, per quanto riguarda la materia che ricade sotto il sigillo sacramentale, in forza dell’art. 4 n. 4 dell’Accordo, il giudice non può esercitare nessun tipo di sindacato, negli altri casi, in primis quello del religioso il giudice deve verificare che l’attività svolta dal religioso sia una attività istituzionale dell’ordine, nonché l’esistenza del nesso di causalità tra l’attività svolta e la notizia ricevuta. Cosa, quest’ultima, che dovrà essere fatta nel caso del sacerdote, qualora si tratti di materia non coperta dal sigillo sacramentale, ma di notizie confidenziali ricevute nell’esercizio del ministero. In conclusione, al di fuori dell’ambito della confessione sacramentale, tanto il sacerdote quanto il religioso si trovano, di fronte alla legge dello Stato, nella stessa condizione di qualsiasi altro professionista [7].
Note
[1] Cfr. P. Nuvolone, Reati di stampa, Giuffrè, Milano 1951, p. 105.
[2] Cfr. art. 622 c.p.: «Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516 [c.p. 31]. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336]».
[3] Cfr. A. Crespi, La tutela penale del segreto, cit., p. 104.
[4] Cfr. A. Crespi, La tutela penale del segreto, cit., p. 108.
[5] Cfr. E. Miragoli – D. Tettamanzi (a cura di), Il sacramento della penitenza, cit., pp. 184-185.
[6] Cfr. A. Crespi, La tutela penale del segreto, cit., p. 100.
[7] Cfr. E. Miragoli – D. Tettamanzi (a cura di), Il sacramento della penitenza, cit., pp. 191-96.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA