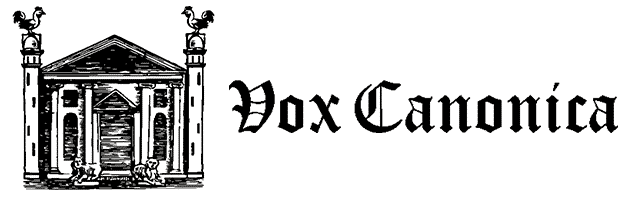Colantonio, particolare del polittico intitolato “San Francesco consegna la Regola”, 1445 circa, museo nazionale di Capodimonte, Napoli
Per poter comprendere le fasi di stesura e il significato della Regola Bollata dei frati minori è necessario tornare alla conversione di Francesco e alla sua visione. L’Assisiate, una volta incontrato il Signore, dopo un lungo e sofferto percorso di ricerca [1], non vuole altra Regola all’infuori del Vangelo come riporta il suo Testamento: “Lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo” [2]. Ma il rapido incremento numerico dei frati, l’istituzione dei capitoli generali, le difficoltà con i vescovi e i sospetti di eresia che la presenza dei frati risvegliava in alcuni luoghi necessitavano di una organizzazione strutturale, di norme chiare.
Dalla Regola non bollata alla Regola bollata di Francesco
Francesco non abdica al suo primo proposito di vivere il vangelo alla lettera, infatti infarcisce la Regola non Bollata del 1221 di innumerevoli citazioni bibliche che però non troveranno più luogo o saranno comunque ridotte nella Regola Bollata del 1223 approvata dal papa Onorio III mediante la bolla Solet Annuere. Il secondo testo ha sicuramente un sapore e una concretezza di tipo giuridico che nel primo erano più latenti, si passa da ventiquattro a dodici capitoli, anche le battute sono meno della metà. Una volta individuata la ratio di una norma il legislatore procede alla sintesi. Un esempio utile potrebbe essere in tempi più recenti la riforma del Codice di Diritto Canonico del 1983 che passa da 2414 canoni del Codice Pio Benedettino del 1917 agli attuali 1752. Proprio un approccio ermeneutico giuridico potrebbe permetterci di entrare nel vivo della Regola e ripercorrerne i passi della stesura.
Come fa notare lo studioso Fernando Uribe nella RegB si hanno dei paragrafi che hanno un marcato stile giuridico, “per la stessa forma complessa di coordinare e subordinare le frasi” [3]. È il caso del capitolo II, 3-6: “E se credono tutte queste cose e le vogliono fedelmente professare e osservare fermamente fino alla fine; e non hanno mogli o, qualora le abbiano, esse siano già entrate in monastero o abbiano dato loro il permesso con l’autorizzazione del vescovo diocesano, dopo aver fatto voto di castità; e le mogli siano di tale età che non possa nascere su di loro alcun sospetto; dicano ad essi la parola del santo Vangelo, che vadano e vendano tutto quello che posseggono e procurino di darlo ai poveri (Cfr. Mt 19, 21). Se non potranno farlo, basta ad essi la buona volontà”.
Un testo sempre più giuridico
Rimanendo sul capitolo II, nei primi due stichi possiamo notare una normazione ben precisa riguardo a coloro che vogliano entrare nella famiglia minoritica: “Se alcuni vorranno intraprendere questa vita e verranno dai nostri frati, questi li mandino dai loro ministri provinciali, ai quali soltanto e non ad altri sia concesso di ammettere i frati. I ministri, poi, diligentemente li esaminino intorno alla fede cattolica e ai sacramenti della Chiesa”. Infatti nella precedente Regola tutti erano ammessi, bastava avere la “divina ispirazione” (RegNB XII, 7) per potere essere accolti benignamente dai frati, senza passare dai ministri.
La ratio è quella di evitare che qualsiasi invasato, celandosi dietro una millantata volontà divina, potesse entrare nell’Ordine dei frati minori. Nel capitolo X della RegB, di cui noi ci occuperemo, la sistemazione normativa è ancora più evidente grazie all’aggiunta di alcuni termini specifici che richiamano alla responsabilità e al rispetto dei ruoli. Subito nel primo paragrafo troviamo l’aggiunta “correggano” (corrigant) rispetto alla RegNB cap. IV, 2 in cui ai “ministri e servi” si comanda: “visitino [i loro frati] e spiritualmente li esortino e li confortino (confortent)”. Confortent lascia il posto a corrigant. I poteri giuridici del ministro sono ampliati, si inizia così a strutturare un testo sempre più giuridico [4].
Tanto più che il Concilio Lateranense IV (1215) aveva comandato ai visitatori dei monasteri di “correggere e di riformare ciò che ha bisogno di correzione e riforma” [5]. Correggere non vuol dire puntare il dito contro il fratello ma uscire e andare verso di lui, come chi va incontro alla “pecora smarrita”, appunto utilizzando “umiltà e carità”. Il silenzio di fronte alla colpa troppo spesso non vuol dire misericordia ma codardia, comodità egoistica o addirittura connivenza da parte di chi esercita il servizio dell’autorità. Altro termine dal sapore prettamente giuridico che troviamo nel capitolo di nostra pertinenza è quello di “sudditi” (X, 2) che nella RegNB non compare mai mentre nel testo approvato da Onorio III lo ritroviamo anche nell’ultimo capitolo (XII, 4) per indicare ai frati la fedeltà alla Chiesa.
È interessante notare come i frati siano sudditi di “ministri e servi” (non priori RegNB VI, 3), non una semplice espressione tautologica ma un rafforzativo che non transige sul valore del servizio. Il frate minore o è servo o non è, i figli del Poverello devono essere consci che governare equivale a servire, è un atto d’amore. Se governare diventa davvero un atto d’amore non sarà difficile seguire chi cerca il tuo bene, chi cerca di farti fiorire nelle tue qualità. Solo così non sarà difficile essere suddito di chi ti serve, sull’esempio di Colui che è venuto per servire e non per essere servito (Mt 20, 2 RegNB IV, 6).
Vita – Regola
Nella parte centrale del capitolo X i ministri sono chiamati a mettere a loro agio i frati in difficoltà affinché “possano parlare con loro come fanno i padroni con i loro servi” (RegB X, 5). Il paradigma della società medievale piramidale è completamente ribaltato: “I ministri siano i servi di tutti i frati” (RegB X, 6). Prima dell’avvento dell’Assisiate vigeva il modello teologico di origine neoplatonica legato allo Pseudo Dionigi l’Areopagita per cui la gerarchia celeste si riproponeva identica e immutabile in quella ecclesiale: il potere, originandosi da Dio, discendeva in maniera ordinata e graduale dalla somma autorità ai livelli inferiori.
Ciò che invece emerge in maniera netta nella famiglia religiosa voluta da Francesco è che quanto più grande sarà la responsabilità, maggiore dovrà essere il servizio. Un ultimo termine di questo capitolo che ci conferma l’idea di una precisa volontà di rendere il testo più giuridico è la sostituzione della parola “vita” usata nella stesura precedente (RegNB VI, 1) con il sostantivo “Regola” (RegB X, 4). Il riferimento è ai frati che fanno fatica a seguire lo stile minoritico che hanno scelto liberamente. Si abbandona così l’antico termine “vita” per quello giuridicamente più tecnico di “Regola” [6].
Continua…
Note
[1] Cf. 1Cel 22: FF 356; 3Comp 25: FF 1427; LegM 3: FF 1031-1032.
[2] Test. 14: FF 116.
[3] F. Uribe, La Regola di san Francesco. Lettera e spirito, Bologna: Edizioni Dehoniane, 2011 p. 33.
[4] Cf. P. Maranesi, La relazione tra fratelli, in P Maranesi e F. Accrocca (a c. di), La Regola di Frate Francesco, Padova: Editrici Francescane, 2012, pp. 516-521.
[5] Lateranense IV, can. 12, in Conciliorum (Ecumenicorum Decreta, 241, 1. 14-16).
[6] Cf. P. Maranesi, La relazione tra fratelli, Op. Cit. p. 526.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA