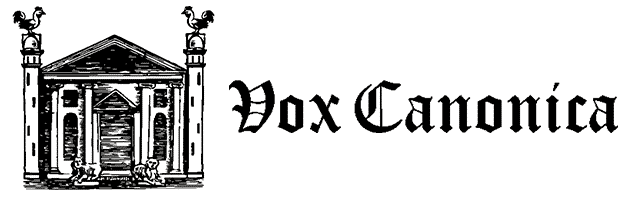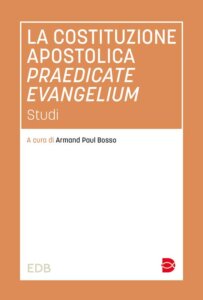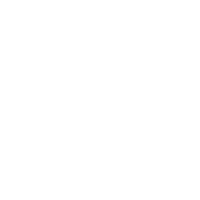Vox Canonica ha dato ampio spazio alla riforma della Curia romana attuata da papa Francesco con la Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, partecipando alla conferenza stampa di presentazione e dedicando al tema vari articoli di approfondimento QUI e QUI. All’inizio di quest’anno, per le edizioni EDB è stato date alle stampe un nuovo volume che non è altro che una collettanea che vari docenti delle università romane hanno realizzato. Il corposo testo presenta la storia dei dicasteri e offre un commento delle linee guida programmatiche che la Costituzione Apostolica predispone per l’implementazione della riforma, evidenziando sia i punti di continuità sia le novità legislative.
Il curatore del testo è il professor Armand Paul Bosso, docente consociato presso la Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana, a lui abbiamo rivolto qualche domanda così che possa aiutarci ad approfondire il lavoro che ha svolto e per il quale lo ringraziamo.
Professore, il testo che ha curato, analizza la costituzione apostolica Praedicate evangelium, qual è l’iter che ha portato alla redazione del testo?
Il progetto di questa opera è nato dopo un contributo offerto al Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (GIDDC), sul nuovo Dicastero per l’Evangelizzazione secondo la nuova costituzione apostolica Praedicate evangelium, nel mese di luglio 2023. Sono stato poi incoraggiato nel mio desiderio di proporre un tale studio dalla lettura del lavoro offerto alla scienza canonica da A. Bonnet e C. Gullo sulla Costituzione apostolica Pastor Bonus. Opere di questo tipo resistono alla prova del tempo e sono innegabilmente utili sia per lo studio che per la cultura e il lavoro dei praticanti. Così, dopo aver ascoltato i consigli di professori più esperti – e qui desidero esprimere un sincero ringraziamento ai professori Luigi Sabbarese e Carlo Jose Errazuriz – ho iniziato i diversi lavori in merito.
Il libro che ha curato è formato da diversi contributi di altrettanti professori, molti dei quali hanno idee, linee di pensiero e sensibilità diverse fra loro. Ci racconti com’è nato questo progetto.
Per dire la verità, la scelta degli Autori si è basata sulla mia stima personale per ognuno di loro. Ho potuto entrare in contatto con loro a livello personale e attraverso le loro produzioni scientifiche. Come sapete, ogni manoscritto racconta qualcosa del suo autore. E così, sono stato spinto verso ognuno di loro. Inoltre, volevo arricchire la qualità dell’opera con una serie di potenzialità. Ripercorrendo le linee di questo lavoro, posso dire che il commento della nuova costituzione apostolica è riuscito a unire i vari scienziati coinvolti intorno a un’unica verità: il bisogno di comprendere i nuovi orientamenti del governo centrale della Chiesa universale. Infine, devo dire che nel ricorrere alla competenza di alcuni Officiali dei Dicasteri romani, sono stato spinto dal desiderio di produrre un’opera in cui si sentisse l’impronta specifica delle persone che collaborano con la Curia Romana, e quindi un’opera basata realisticamente sulle opinioni di Autori che hanno una buona conoscenza delle realtà coinvolte.
C’è un filo rosso che lega l’intera Praedicate Evangelium?
A mio parere, sì. Questo filo conduttore è la coerenza del Pontefice con la dinamica di conversione missionaria in cui ha voluto inserire tutte le strutture della Curia Romana, in continuità con l’Esortazione apostolica Evangelii gaudium. La costituzione apostolica Praedicate Evangelium è l’espressione giuridica della linea dottrinale, pastorale e amministrativa con cui Papa Francesco ha voluto che si realizzi il governo centrale della Chiesa. Il governo centrale della Chiesa universale è al servizio delle Chiese particolari.
La natura di questo servizio stabilisce una relazione di reciprocità e di complementarità tra la Curia Romana e i vari Vescovi a capo delle loro Chiese. Ma, la dinamica va ben oltre questa dimensione verticale e ha implicazioni anche sulla natura orizzontale delle relazioni con il “Santo Popolo di Dio” in generale. Papa Francesco, ha promosso una nuova linea ecclesiologica, quella del Santo Popolo di Dio, in cui l’inclusività e l’unitarietà sono promosse nella comune partecipazione alla missione della Chiesa. Naturalmente, ci vorrà ancora del tempo per comprendere i diversi aspetti di questa linea in relazione all’ecclesiologia di comunione, e soprattutto per rendersi conto di ciò che essa implica in termini concreti.
A quale principio si è ispirato il Legislatore nella redazione della Praedicate evangelium?
Il principio chiave che ha guidato il Legislatore nella stesura del Praedicate evangelium è stata la conversione missionaria delle strutture della Curia Romana. Per il Legislatore universale, ciò significava riportare la Curia Romana al suo compito originario, che è quello di essere al servizio del Successore di Pietro nell’esercizio del suo supremo ufficio pastorale per il bene e il servizio della Chiesa universale e delle Chiese particolari. Pur essendo un organismo esecutivo, la Curia Romana svolge la sua missione in una dimensione pastorale (e non burocratica), perché è chiamata a testimoniare l’indefettibile rapporto di comunione che unisce il Popolo di Dio.
Pertanto, principi come la collegialità e la sinodalità sono tra gli obiettivi che devono riflettersi nei suoi rapporti sia con le istituzioni interne sia con le altre istituzioni proprie dell’organizzazione della Chiesa universale (come le Chiese particolari, le Conferenze episcopali, le unioni regionali o continentali di Conferenze episcopali, le strutture gerarchiche orientali, ecc.). Insomma, il principio ispiratore di questa nuova Costituzione apostolica è far sì che la Curia Romana rifletta il volto missionario della Chiesa.
Quali sono le principali novità nella nuova Costituzione Apostolica?
Per quanto riguarda l’originalità di questa nuova Costituzione Apostolica sulla Curia Romana, ci sono sicuramente molti punti da sottolineare. I più interessanti mi sembrano il coinvolgimento dei non-ordinati nella partecipazione alla potestà vicaria attraverso le funzioni di presidenza dei dicasteri curiali (cioè la concretizzazione del munus regendi dei fedeli non ordinati), la “sana decentralizzazione” e la vicinanza della Curia Romana al Popolo di Dio.
Sul primo punto, il n.5 dei Principi e criteri per il servizio della Curia Romana è molto espressivo. Anche se le implicazioni giuridiche non sono ancora oggetto di una pacifica ricezione, i fatti dimostrano che in alcuni uffici vicari, che non richiedono necessariamente l’abilitazione sacramentale derivante dall’Ordine sacro, i non-ordinati possono essere utili per lo sviluppo della missione della Chiesa. Se è vero che il Papa voleva inizialmente reagire contro i pericoli di relazioni asimmetriche nell’espressione della collaborazione tra ordinati e non-ordinati, la verità è che i fedeli non-ordinati negli uffici di presidenza dei Dicasteri sono una prova tangibile della ordinatio ad invicem caratteristica della corresponsabilità ecclesiale.
In relazione al processo di “sana decentralizzazione”, la Praedicate evangelium vuole “lasciare alla competenza dei Pastori la facoltà di risolvere nell’esercizio del loro proprio compito di maestri e di pastori le questioni che conoscono bene e che non toccano l’unità di dottrina, di disciplina e di comunione”. Questa innovazione è espressione di un certo pragmatismo amministrativo. Su questo punto, un passo è già stato fatto con il m.p. Competentias quasdam.
Infine, per quanto riguarda la vicinanza al Popolo di Dio, l’articolo 1 della Costituzione Apostolica ci ricorda che la Curia Romana è chiamata a svolgere la propria funzione in spirito evangelico, lavorando per il bene e al servizio della comunione, dell’unità e dell’edificazione della Chiesa universale, e rispondendo alle necessità del mondo in cui la Chiesa è chiamata a svolgere la sua missione. Grazie a Vox canonica per questa opportunità e per lo stimato impegno nella diffusione della scienza canonica.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA