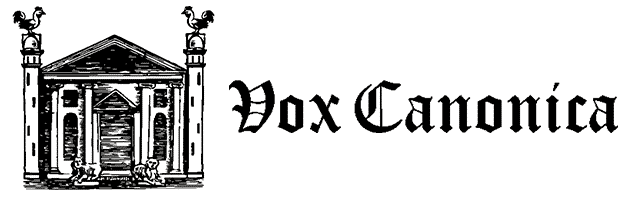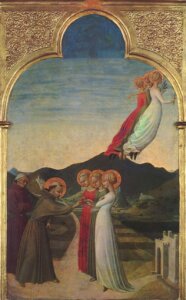Domenica 7 settembre due nuovi santi sono saliti all’onore degli altari: Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Un evento che ha richiamato migliaia di fedeli a Roma e che ripropone una domanda antica quanto attuale: che cosa significa diventare santi e perché la canonizzazione ha tanta importanza? Per la Chiesa, la dichiarazione ufficiale di santità non è un mero titolo d’onore. Si tratta piuttosto di un dono che Dio concede al suo popolo, un segno straordinario della sua azione nella storia. Attraverso la canonizzazione, infatti, il Papa proclama solennemente che un battezzato ha vissuto in pienezza il Vangelo e lo propone come modello universale di vita cristiana.
Il processo che porta a questo riconoscimento è tutt’altro che semplice. Generalmente parte dal basso, sono i fedeli che, avendo conosciuto il defunto, si fanno promotori della sua fama di santità. Nel linguaggio canonico questi promotori sono detti Attori. Essi incaricano un Postulatore, figura che assume il ruolo di avvocato della causa, raccogliendo documenti, testimonianze e prove che confluiranno nell’instrumentum probatorium. L’iter prende due strade ben distinte: una prima fase diocesana e una successiva fase romana. Ma su questo torneremo più nel dettaglio in un prossimo approfondimento.
Fama di santità o di martirio e di segni
Nessuna causa di canonizzazione può cominciare senza un requisito fondamentale: la cosiddetta fama sanctitatis. In termini semplici, si tratta della convinzione diffusa tra i fedeli che una persona abbia vissuto in modo integro, puro e con virtù esercitate in grado eroico. Se, invece, si tratta di un martire, la Chiesa richiede la fama martyrii, cioè l’opinione condivisa che la morte sia stata subita “in odium fidei”, in odio alla fede, o a una virtù direttamente legata ad essa [1].
A questo primo passo se ne affianca subito un altro: la fama signorum. Con questa espressione si indicano i segni, i prodigi e i miracoli attribuiti all’intercessione del Servo di Dio. Non basta, infatti, che la comunità riconosca la sua santità, occorre anche che Dio stesso lo confermi attraverso grazie ricevute e testimonianze concrete di favori inspiegabili.
Perché sia ritenuta autentica, la fama deve possedere alcune caratteristiche ben precise: deve essere stabile, continua, diffusa e mai artificiosamente costruita. Inoltre, deve coinvolgere una parte significativa del Populus Dei, ossia un numero apprezzabile di fedeli.
Il giudizio sulla rilevanza e sulla genuinità della fama si fonda sull’analisi congiunta delle cosiddette tre voci: Vox populi (la voce del popolo), Vox Dei (la voce di Dio, comprovata dai segni) e Vox Ecclesiae (la voce della Chiesa, che discernendo raccoglie e certifica). L’esistenza di un’autentica e ben diffusa fama è il requisito teologico e canonico, fumus boni iuris, che permette al Vescovo di iniziare la causa e istruire l’inchiesta.
Cosa viene dichiarato: beatificazione e canonizzazione
La Chiesa non “crea” la santità ma la riconosce. È bene chiarirlo subito, il compito dell’autorità ecclesiastica, nei processi di beatificazione e canonizzazione, non è inventare o costruire un’aura di santità attorno a un fedele, ma discernere, vagliare le prove e poi dichiarare pubblicamente ciò che Dio ha già operato nella vita di quella persona.
In questo percorso, però, è fondamentale distinguere due tappe: beatificazione e canonizzazione. La prima può essere considerata come una via intermedia, necessaria per giungere all’onore degli altari. Con la beatificazione, infatti, il Papa autorizza che un Servo di Dio sia venerato con il titolo di beato. Ma attenzione, si tratta di un culto “permissivo” e non obbligatorio, e geograficamente circoscritto o limitato ad un Ordine religioso particolare o a più famiglie religiose, oppure ad una o più diocesi, ma non esteso alla Chiesa universale.
La canonizzazione, invece, è tutta un’altra cosa. Qui il giudizio della Chiesa si fa definitivo e universale: il Romano Pontefice ordina che quel fedele sia venerato come santo da tutta la comunità cattolica. È un atto solenne, precettivo e irrevocabile, con cui la Chiesa propone quella figura come modello valido per l’intero Popolo di Dio.
Le vie della santità: martirio, esercizio eroico delle virtù, offerta della vita
Il Martirio
Nei primi tre secoli della Chiesa, il martirio fu la via maestra per la santità. Per i cristiani delle origini, morire a causa della fede era la testimonianza più alta di amore a Cristo e di fedeltà al Vangelo. Non a caso sant’Agostino scriveva: «Martyres non facit poena sed causa», non è la pena della morte a fare il martire, ma la causa per cui la si affronta [2]. In altre parole, non basta subire una condanna o una violenza, ciò che rende martire è il motivo della sofferenza, l’odio alla fede del persecutore e l’accettazione libera da parte della vittima.
Nella configurazione odierna del diritto canonico, tre sono i requisiti indispensabili per riconoscere un vero martirio: la morte fisica realmente avvenuta (martirio materiale); l’esistenza dell’odium fidei come causa della morte, (martirio formale ex parte persecutoris); la libera accettazione della morte motivata dall’amore della fede da parte della vittima (martirio formale ex parte victimae). Il Dicastero delle Cause dei Santi, per ogni caso, compie un esame rigoroso di carattere storico e giuridico, verificando che ci sia corrispondenza tra i fatti accertati e il modello teologico del martirio. C’è poi un aspetto importante da sottolineare: per proclamare beato un martire non è richiesto il riconoscimento di un miracolo. Per la canonizzazione, invece, secondo la prassi corrente, la Chiesa attende sempre la conferma di un evento miracoloso postumo alla morte del Servo di Dio, come segno ulteriore del favore divino.
Esercizio eroico delle virtù
Con l’editto di Milano del 313, il cristianesimo cessò di essere perseguitato e divenne religione lecita. La fine delle persecuzioni segnò anche un cambiamento decisivo nel modo di riconoscere la santità: non era più l’effusione del sangue a costituire la via maestra, ma la testimonianza quotidiana di una vita evangelica. Nacque così il culto dei santi confessori, uomini e donne che, pur senza subire il martirio, seppero confessare e praticare la fede in modo esemplare. La loro santità si manifestava non solo nella condotta virtuosa, ma anche attraverso i miracoli attribuiti alla loro intercessione, sia in vita sia dopo la morte.
In questo contesto si affermò il concetto di virtù eroica, che la tradizione patristica e poi la teologia scolastica definirono con precisione. San Tommaso d’Aquino parlava della virtù come di un habitus operativus, una disposizione stabile a compiere il bene: «virtus humana, quae est habitus operativus, est bonus habitus et boni operativus»[3]. L’eroicità non riguarda un gesto isolato, ma la costanza con cui una persona vive le virtù supra communem modum, cioè “facilmente, prontamente e piacevolmente sopra la misura comune per un fine soprannaturale”, come precisò il Magister Benedetto XIV. È, in altre parole, la sequela radicale del Vangelo, protratta nel tempo oltre la media dei giusti. La prassi corrente richiede il riconoscimento delle virtù eroiche, necessità di un primo miracolo per la beatificazione avvenuto dopo la morte del Servo di Dio e per sua intercessione; un secondo miracolo per la canonizzazione.
Offerta della vita
Una delle vie più recenti verso la santità è quella dell’“oblatio vitae”. È stata introdotta ufficialmente da papa Francesco con il motu proprio Maiorem hac dilectionem, promulgato l’11 luglio 2017. Questa forma di riconoscimento apre la strada alla beatificazione — e successivamente alla canonizzazione — di chi ha scelto volontariamente e liberamente di donare la propria vita per gli altri, perseverando fino alla morte in questo atto supremo di carità.
L’offerta della vita, affinché sia valida ed efficace per la beatificazione di un Servo di Dio, deve rispondere ai seguenti criteri: a) offerta libera e volontaria della vita ed eroica accettazione propter caritatem di una morte certa e a breve termine; b) nesso tra l’offerta della vita e la morte prematura; c) esercizio, almeno in grado ordinario, delle virtù cristiane prima dell’offerta della vita e, poi, fino alla morte; d) esistenza della fama di santità e di segni, almeno dopo la morte; e) necessità del miracolo per la beatificazione, avvenuto dopo la morte del Servo di Dio e per sua intercessione. Per la canonizzazione la presenza di un secondo miracolo [4].
La santità non è un privilegio
La canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati ricorda che la santità non è un privilegio riservato a pochi eroi del passato, ma una possibilità concreta e attuale. Le vie tracciate dal diritto canonico — martirio, virtù eroiche, offerta della vita e, in casi eccezionali, la conferma di un culto antico — sono i percorsi attraverso cui la Chiesa riconosce ciò che lo Spirito Santo suscita nel Popolo di Dio. Frassati, con il suo impegno instancabile per i poveri e la vita comunitaria, e Acutis, con la sua quotidiana testimonianza di fede nel mondo digitale, dimostrano che la santità può incarnarsi in forme diverse ma complementari.
Entrambi mostrano che vivere il Vangelo con coerenza, generosità e passione è possibile in ogni epoca e in qualsiasi contesto. Le loro canonizzazioni non sono soltanto il suggello di un processo giuridico: sono un invito concreto ai fedeli di oggi. Come ricorda la Lumen Gentium, tutti i battezzati sono chiamati alla santità, ciascuno secondo la propria vocazione e le circostanze della vita. La santità, quindi, non appartiene a un tempo remoto né a pochi privilegiati: è una vocazione universale e quotidiana, realizzabile attraverso i gesti, le scelte e la dedizione che ciascuno può compiere nel proprio tempo e nella propria vita.
Note
[1] BENEDETTO XVI, De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione, L. II, cap. 39, n. 7.
[2] AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Enarrationes in Psalmos, 34, sermo 2, n. 13.
[3] THOMAS AQUINAS , Summa Theologiae, Ia IIae, q. 55, a.3.
[4] FRANCISCUS PP., M.p. Maiorem hac dilectionem. Sull’offerta della vita, art. 2.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA